C’è un modo di fare teatro che non si accontenta della superficie, che sceglie di sporcarsi le mani rovistando tra le macerie della storia e dell’anima umana. È quello che fa la compagnia Campsirago con “Barbablù”, in scena a Spazio Teatro: un lavoro stratificato, inquieto, che prende un archetipo – quello del mostro, del carnefice – e lo rigira ossessivamente fino a mostrarne tutte le facce.
Michele Losi dirige Benedetta Brambilla e Sebastiano Sicurezza in una drammaturgia a incastri firmata da Sofia Bolognini. E già questa definizione – “a incastri” – dice molto: non c’è linearità narrativa, ma sovrapposizioni, cortocircuiti tra epoche e storie. Campsirago, da oltre 25 anni laboratorio di ricerca che attrae artisti da tutta Italia e mezza Europa, conferma la sua vocazione: tenere vivo un teatro che interroga, che non dà risposte facili.
Sul palco due giovani corpi in movimento frenetico, preciso, ma mai meccanico. La colonna sonora arriva da un mangianastri, musica su cassette che evoca un tempo analogico, tangibile. E dentro questo dispositivo scenico si dipanano spirali di violenza: i due protagonisti sono testimoni, vittime, e infine – inevitabilmente – carnefici. Perché questo è il nucleo drammaturgico dello spettacolo: la violenza come catena, come eredità che si trasmette, come virus che contamina chi cerca di spezzarla.
Da una cassa magica – archivio di memorie e oblio – emergono brandelli di jeans. Pezzi di tessuto blu, azzurro, che invadono progressivamente la scena formando cumuli leggeri ma che nell’insieme diventano pesanti, soffocanti. È un’immagine potente: quelle discariche di denim evocano il consumismo come forma di controllo, i marchi che ci rendono schiavi, il capitalismo come violenza sistemica e invisibile. Non è solo metafora: è denuncia materiale, fisica.
Chi è Barbablu?
La drammaturgia sceglie di abbandonare la fiaba di Perrault, troppo rassicurante nella sua morale da “camera proibita”, per attingere a fonti più oscure e disturbanti. Ci sono i gemelli della Trilogia della città di K di Ágota Kristóf, con la loro educazione alla crudeltà come forma di sopravvivenza. C’è “The Basement”, con le sue perversioni claustrofobiche. E soprattutto c’è la storia vera di Gilles de Rais, il feudatario di Rouen che fu luogotenente di Giovanna d’Arco prima di trasformarsi in serial killer di bambini. Un uomo che godette di anni di impunità grazie al suo potere, finché la caduta del sistema feudale non lo consegnò alla forca. Da lì nacque il Barbablù della memoria collettiva: l’uomo nero, il terrore dei più piccoli.
Un fatto che richiama il caso Epstein, i potenti impunibili, le reti di complicità che proteggono i predatori. Predati e predatori con caratteristiche simili eppure diametralmente opposti per vivere o essere soppressi. Animali come persone. Come dice Losi, c’è un’interrogazione aperta sulla violenza sistemica, sul potere che si perpetua, sui cicli di sopraffazione che attraversano i secoli. Ma c’è anche – ed è forse la questione più dolorosa – il tema della violenza intergenerazionale, quella che si trasmette di padre in figlio, di madre in figlia. La violenza di genere. Il patriarcato inteso non come astrazione ideologica ma come struttura concreta che plasma i corpi e le relazioni.
Gli attori lo chiariscono a fine spettacolo: queste riflessioni sono state il punto di partenza, non la fiaba o la ricostruzione storica. L’obiettivo era entrare nel “mare del barbabluismo“, inteso come attitudine al potere e al controllo sull’altro. E questo barbabluismo, spiegano, lo abbiamo incontrato tutti: nelle sottigliezze delle relazioni tradizionali, nei piccoli gesti quotidiani di prevaricazione che normalizziamo.
Il teatro contemporaneo – quando è vero, quando non si rifugia in estetismi compiaciuti – fa esattamente questo: ci mette di fronte a domande scomode. Non offre soluzioni, non propone catarsi consolatorie. Apre questioni. “Come si può perdonare l’imperdonabile?” chiedono dalla scena. E nella sala cala un silenzio pesante, perché quella domanda non ha risposta facile. Forse – suggeriscono – solo Mandela in Sudafrica, con il suo straordinario lavoro di riconciliazione, ci è riuscito davvero.
Da teatro esco con tanti punti interogativi e una mole di pensieri: ed è questo il regalo più prezioso che il teatro possa fare: non risposte preconfezionate, ma domande che continuano a lavorare dentro, a scavare, a non lasciarti in pace.




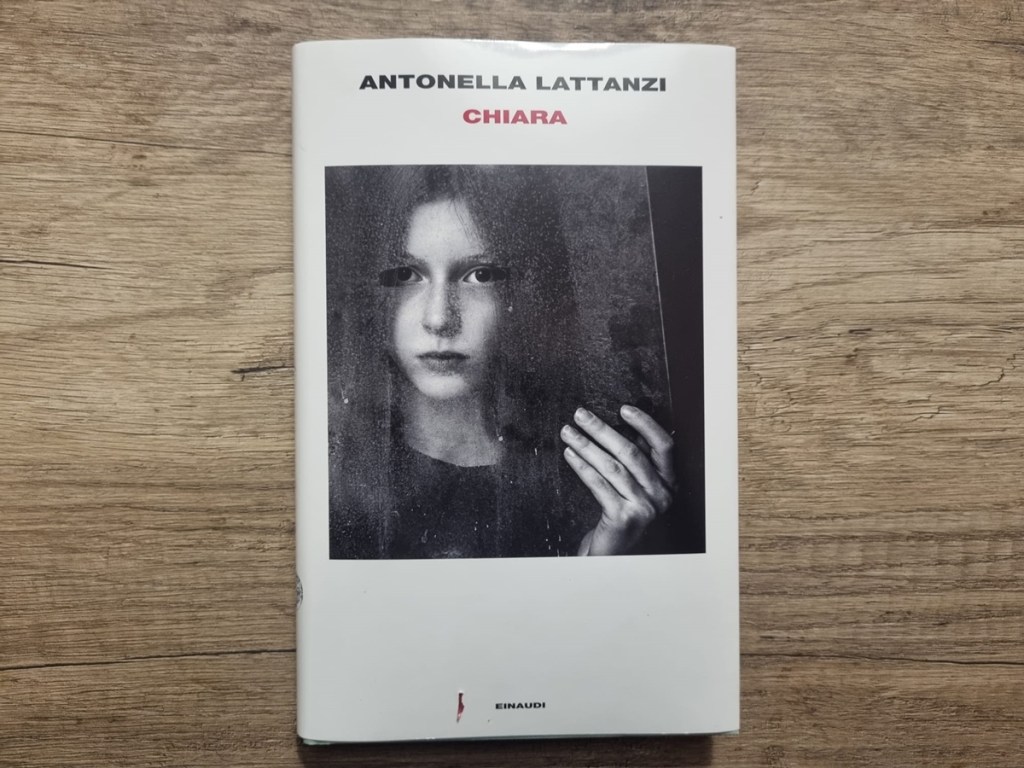
Lascia un commento